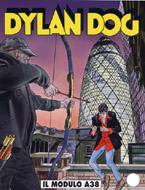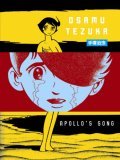Ma manca davvero un nuovo sito di critica sul fumetto in Italia?
E ammesso che sì, intuitivamente, e d’istinto, e per le buone ragioni, accettiamo questo bisogno, ecco, a chi appartiene veramente?
Ai lettori di fumetti?
Ai lettori generalisti?
Agli autori?
Agli editori?
Ai loro uffici stampa?
Ai distributori?
Ai critici stessi?
Ammettiamo anche che un buon sito di critica serva all’insieme comune di questi interlocutori. E fingiamo anche che esista un punto di equilibrio capace di accontentare i molteplici bisogni di tutti loro.
Allora mi chiedo, quale tipo di critica serve? È un tipo di critica che manca? O il perfezionamento (la fusione, la mediazione, lo sviluppo) di qualcosa che già esiste?
Seguendo il buon senso della concretezza, dovremmo allontanarci dai principi e dai poeti, e ritornare alle persone, ché la critica è anche (e soprattutto) una prassi, realizzata appunto da singole persone sole o associate (aggregate, coagulate, … le metafore potrebbero essere molte). Esistono molteplici motivazioni che spingono le persone a fare critica, e se ne è parlato a dismisura. Ma non si parla mai, o quasi, delle funzioni (umane) cui tale esercizio risponde e che sono, in qualche modo, sottostanti. Le funzioni cui mi riferisco sono eterogenee, e hanno a che fare con: il piacere di condividere interessi e idee; la bellezza di confrontarsi su opere di ingegno umano; più prosaicamente, la voglia di occupare tempo durante lunghe e noiose ore di lavoro al pc; la determinazione ad affermare la propria idea, il proprio io nell’ossario egoico della rete; la convinzione di saper aggiungere qualcosa di nuovo a quanto già è stato detto; la volontà belligerante di attaccare e sconfiggere presunti antagonisti (ideologici o professionali); il desiderio di ottenere più potere, all’interno di un contesto circoscritto e fortemente personalistico; l’amore per l’esercizio della parola scritta; …
Tante, troppe le funzioni sottostanti all’esercizio critico. Costituiscono il non detto di un’attività umana complessa. E allora serve onestà. Prima di pensare a quali obiettivi o finalità un sito di critica sul fumetto debba avere, è fondamentale che il critico per primo comprenda le funzioni che lo guidano e ne riveli i meccanismi. Solo in questo modo, credo, sarebbe possibile per la critica diventare più seria, adulta, credibile.
Altrimenti, ogni espressione critica risulta impossibile, perché strumentale e, in definitiva, irreale.
Harry