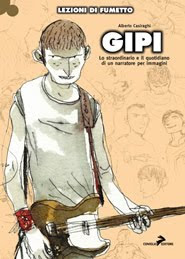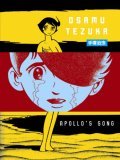[...] L'artista moderno ha nostalgia dell'aristocrazia e della struttura sociale precedente: da Stendhal a Baudelaire e Flaubert, i fondatori della modernità odiano la democrazia e condannano il denaro, giacché se ne deve ovviamente possedere, ma senza parlarne, e soprattutto senza guadagnarne - tale è precisamente la condizione dell'aristocratico. L'artista [...] vuole essere riconosciuto, ma nulla lega più la sua musica a un pubblico che si è democratizzato. Non gli resta dunque che oscillare fra il desiderio di ritirarsi nella propria torre d'avorio e di ribellarsi contro una società che lo ignora.
martedì 5 aprile 2011
L'impossibile critica (2ter) - il modernista aristocratico
domenica 3 aprile 2011
L'impossibile critica (2bis) - il modernista
Forse la nascita dell'arte avverrà nel momento in cui l'ultimo uomo disposto a guadagnarsi da vivere con l'arte se ne sarà andato, e per sempre.
martedì 22 marzo 2011
In gita scolastica: quello che osservo quando osservo
Fermo nel centro di una cittadina, seduto su una panchina, sole e pranzo e vento e una fontana brutta, puntuta, circolare, inutile. Ricordo l'anno della costruzione. Ricordo di aver pensato che merda, quando fu inaugurata.
Il silenzio del vento e dello scorrere dell'acqua è interrotto da grida di bambini. Una classe elementare passa a sciame, cappellini gialli in testa, panini di McDonald's. Ai polsi di molti di loro pende una digitale. Molti si fermano, osservano e fotografano la fontanaccia. Disposizione d'animo, penso. Sono in visita a una città e la loro mente è programmata per ricercare cose belle, o più probabilmente, cose da fotografare. Logica da consumo, come in tutto. Neppure testimonianza. Il digitale, poi, tolto il peso del costo del rullino e della stampa, livella le scelte verso il basso: nel dubbio, scatto.
Cosa osserviamo quando osserviamo? Quando guardiamo un fumetto, muovendoci tra le vignette, quali scatti facciamo? Dove si ferma più a lungo il nostro sguardo, a memorizzare, interpretare, attribuire? Il nostro gusto, di dipendenti visivi, è livellato verso il basso? L'abitudine digitale, ripetizione identica a se stessa, senza supporto tangibile, come si riversa nella lettura di un tradizionale fumetto cartaceo? Cosa sfugge al nostro sguardo, perché abituati ad altro? Siamo in gita, quando guardiamo un fumetto, cappello giallo in testa e hamburger, più interessati alle relazioni sociali, a quella sensazione di libertà mista a eccitazione, che a riconoscere cosa realmente vale, rimane, persiste? In questo, nell'essere in gita, si può riassumere il concetto di evasione, di intrattenimento di questa post-modernità?
Harry
venerdì 25 febbraio 2011
L'amore immobile nello studio di Munari
Scrivo in treno, circondato da persone che occupano la mente con giochi al cellulare talmente minuscoli da essere incomprensibili e con i quotidiani gratuiti, hai presente, quei fogli di carta che leggi per convincerti di essere aggiornato su quel che ti succede intorno.
Scrivo e rifletto su un cambiamento di paradigma. Quando osservi le donne che ti si muovono intorno, c’è un meccanismo automatico che le associa alle protagoniste dell’ultimo show televisivo o alle pornostar più in voga (che sono la stessa cosa, in definitiva). Caparezza la chiama la rivoluzione del sesso in tutto. Ne parla anche Roberto Recchioni, per qualche verso, te lo segnalo di passaggio. Anche se quello che lui indica come eversione mi sembra piuttosto una banale quanto totalizzante perversione nevrotica (e lo dico, sia chiaro, senza alcun giudizio valoriale. In chiave psicopatologica, piuttosto). In questo mi sento più vicino a Spari. Ma torniamo in tema.
Alessandro Baronciani è legato a un vecchio paradigma, quello romantico/nostalgico. Il viso di una donna, i suoi capelli, il suo passo lo riportano alle protagoniste di vecchi film francesi. Basterebbe questo a descrivere lo sguardo di Baronciani nel suo ultimo libro Le ragazze nello studio di Munari (Black Velvet). In questo lavoro appare un autore incapace di raccontare il presente, e un protagonista incapace di vivere il presente. Il libraio innamorato dell’arte di Munari e di tre donne contemporaneamente (o solo di Chiara?), che è protagonista del libro, sembra bloccato in un eterno passato, fatto di ricordi, nostalgie e malinconia abissale. Non accade nulla in questo libro. Nulla che non sia un fotogramma di un evento già chiuso, di un tempo eternamente presente ma sempre fuori fase.
 Sono cresciuto tra le idee e i simboli di Bruno Munari. Il primo ricordo è Le favole al telefono di Gianni Rodari nella copertina di Munari. Il secondo è la scimmia Zizi, ancora oggi tra i giochi di mio figlio. Poi le sue idee, i suoi scritti sul design come nuova forma d’arte (Arte come mestiere), l'unica, a suo dire, in grado di associare la ricerca estetica con la praticità. Le sue idee sulla creatività, sull’educazione e la consistenza, sì consistenza è il termine che mi viene più utile, la consistenza dell’espressione artistica. C’è un progetto in atto da più di dieci anni a Reggio Emilia che si fa capo alla società Reggio Children che si struttura a partire dalle sue idee sulla didattica e l’educazione. Ne puoi leggere in queste riviste. Sono straordinarie, rivoluzionarie e, ahimé, totalmente agli antipodi delle idee attualmente in voga nell’arena politica sulla scuola.
Sono cresciuto tra le idee e i simboli di Bruno Munari. Il primo ricordo è Le favole al telefono di Gianni Rodari nella copertina di Munari. Il secondo è la scimmia Zizi, ancora oggi tra i giochi di mio figlio. Poi le sue idee, i suoi scritti sul design come nuova forma d’arte (Arte come mestiere), l'unica, a suo dire, in grado di associare la ricerca estetica con la praticità. Le sue idee sulla creatività, sull’educazione e la consistenza, sì consistenza è il termine che mi viene più utile, la consistenza dell’espressione artistica. C’è un progetto in atto da più di dieci anni a Reggio Emilia che si fa capo alla società Reggio Children che si struttura a partire dalle sue idee sulla didattica e l’educazione. Ne puoi leggere in queste riviste. Sono straordinarie, rivoluzionarie e, ahimé, totalmente agli antipodi delle idee attualmente in voga nell’arena politica sulla scuola. Non so se Munari si sia mai interessato al fumetto, ma credo che ne avrebbe apprezzato certi sviluppi. Come il lavoro di Baronciani, e le sue trovate cartotecniche, che nascono da un’esplorazione delle possibilità artistiche del maestro. Un lavoro intelligente, ricco di cura e amore.
C’è poi un gioco di Munari che mi capita di utilizzare ancora oggi, si chiama + e – (più e meno) ed è costituito da tante carte lucide con semplici disegni stilizzati. Le carte sono sovrapponibili e il gioco consiste nell’inventare scenari e storie diverse a seconda delle molteplici composizioni di carte. C'è un filmato che ne esemplifica il funzionamento.
È con questo gioco che Baronciani apre il suo libro. Fermiamoci qui. Baronciani fa proprie alcune prospettive narrative e visive di Munari, e le ripropone in fumetto. Lo stesso fa con alcuni principi, come quello sulla risoluzione dei problemi, celebre quanto, boh, utile? Forse. La nostra mente segue percorsi misteriosi. Eppure, questo tentativo di trasformare i rapporti affettivi in design mi sembra contraddire l’essenza stessa dell’approccio di Munari. Questo soffermarsi, isolarsi nel passato, mi sembra un sentimentalismo intellettuale un po’ sterile. Manca di crudeltà, o di concretezza, c’è una suggestione intellettualistica che non mi convince. Un tentativo che forza l’occhio del creativo italiano per assoggettarlo a qualcosa di vecchio, statico, monolingue.
Baronciani, d’altra parte, ha fatto ancor più personale il proprio stile, trovando un equilibrio formale appagante per il lettore. Sa commuovere, sa mostrare la fragilità degli affetti, nell’incapacità di diventare adulti. Ma se in Quando tutto diventò blu il suo sguardo algido e malinconico, in relazione alla malattia, appare felicemente delicato e anti-patetico, in Le ragazze nello studio di Munari sembra traslucido e assordante perché isolato dalla concretezza dell’esistenza. Forse è questa pellicola sottile che Baronciani dovrebbe sollevare, per trovare un rapporto con la vita che, certo, può sporcare, ma può anche permettere un deciso sviluppo delle sue potenzialità espressive.
Harry.
venerdì 7 gennaio 2011
The Newave Manifesto
Why do we go on drawing comix when there is no money in the business? We have no choice. Comix are what we do, the way we express ourselves, the way we react to reality. Ideas come and they have to be drawn, reproduced and passed around. It makes little difference if fifty or fifty thousand people read them. Ideas and their expression are the issue, not quantity or quality... Newave is about art, not money.
Perchè continuiamo a disegnare comix quando non ci sono soldi nell'editoria specializzata? Non abbiamo alternative. I comix sono quello che facciamo, il modo in cui ci esprimiamo, in cui interpretiamo la realtà. Arrivano le idee e devono essere disegnate, riprodotte fatte circolare. Fa poca differenza se li leggonono cinquanta o cinquanta mila persone. Il punto sono le idee e la loro espressione, non la quantità o la qualità... Newave si occupa di arte, non di soldi.
martedì 7 dicembre 2010
Caro figlio mio, aspirante fumettista...
Riflessioni da padre, mentre il Governo tagli ancora i fondi alla cultura.
Caro figlio mio, aspirante fumettista,
desisti. Per quanto tu abbia il gusto per la narrazione a fumetti, ricordati che non avrai modo di guadagnarti da vivere. Troppo pochi, troppo angusti gli spazi per farti le ossa, per sperimentare, per confrontarti con persone che potrebbero aiutarti a crescere. Nella migliore delle ipotesi, potresti trovare un editore che decide di stampare il tuo libro, senza trovare tempo e modo di promuoverti. Nella peggiore, pubblicheresti online cose che dimenticherebbero tutti subito. Forse, se insisiti per caparbietà al limite della cocciutaggine, potresti fare la figura del fumettista della domenica. Lavorerai ai tuoi fumetti la notte, mentre di giorno farai quello che serve alla società e al pagamento dei tuoi debiti. E ti prenderebbero pure per il culo.
Caro figlio, aspirante musicista,
desisti. La SIAE non ti permette di esibirti senza buttare soldi che nessun locale, nessun teatro, nessuna associazione metterebbe al posto tuo. Ricordati che non avrai modo di guadagnarti da vivere, a meno che il tuo viso e le tue canzoni non servano a vendere scarpe, idee e stile. Nella migliore delle ipotesi, se le tue capacità tecniche e ideative te lo permettono, potresti insegnare musica a persone troppo giovani per avere motivazione, o troppo vecchie per poter progredire. Nella peggiore, suoneresti la domenica, in chiesa, innovando con la tua inventiva improbabili inni sacri moderni.
Caro figlio, aspirante scrittore,
desisti. I libri si pubblicano, si stampano, ma non si vendono e, peggio, non si leggono. I tuoi libri assieperebbero librerie che non saprebbero valorizzarti. Potresti arricchire il tuo curriculum o la tua pagina facebook con i titoli e le copertine dei tuoi libri, ma difficilmente troveresti un editore pronto a promuoverti realmente. A meno che il tuo romanzo non possa essere un buono spunto per una sceneggiatura cinematografica. Nella migliore delle ipotesi, potresti partecipare a qualche salotto buono. Nella peggiore, avresti scatoloni di copie dei tuoi libri nel box (eventualmente, avresti speso molti soldi per quelle copie).
Caro figlio, aspirante pittore...
OK, ferma ferma. Facciamo un passo indietro. Perché l'uomo si impegna a realizzare opere artistiche? Figlio mio, senti dentro di te un bisogno, un urgenza? Cerchi una tua voce? Cerchi una strada che ti permetta di trovarti, in questo caos esistenziale? Hai voglia di metterti alla prova? Di sviluppare la tua creatività? Di perfezionare la tua tecnica, al servizio di un diverso modo di esprimerti? Hai voglia di provarti come essere umano completo, che sperimenta, che si mette in gioco, che incontra gli altri e i propri dubbi negli altri?
Cazzo (scusa l'espressione), da che mi ricordo, le cose più importanti, appassionanti, impegnative, esaltanti, gioise, ... che ho fatto nella mia vita non avevano lo scopo di guadagnarci dei soldi.
Ma non fermarti lì. Trova la passione, e in essa il coraggio di proporti, di aprirti, di sentirti serenamente convinto di poter raggiungere gli altri. Ci sono migliaia, milioni di persone nel mondo che quella determinazione, quel coraggio, quella forza, quella vocazione non ce l'hanno. L'hanno dimenticata nelle loro esperienze pregresse, nelle loro vite passate, nei loro antenati, nelle loro paure. Ma hanno bisogno della tua arte, della tua espressività, della tua autenticità, come dell'ossigeno.
Sii serio, e ironico, e forte, e delicato, ma soprattutto chiaro e vero. Forse, troverai un varco, forse troverai i soldi, forse troverai la pace. E ti ricorderai delle ore che hai speso nel fare quello in cui credevi di più come dei momenti migliori della tua vita.
Harry
domenica 25 luglio 2010
La morte ti fa bella
Ti avviso, se leggi Jan Dix e non hai ancora letto l’ultimo numero della serie, qui ti svelo il finale.
Jan Dix è la maxi serie di Carlo Ambrosini che termina in luglio con il quattordicesimo numero. La conclusione era prevista, ma con qualche speranza, a differenza di chiunque coinvolto nel progetto ti dirà oggi. La speranza era che, come successe per Napoleone, le vendite permettessero un prolungamento oltre i quattordici numeri. Anche per questa ragione, Jan Dix è concepita come una serie slegata di episodi, senza un inizio e una fine predefeniti, in uno sviluppo coerente. Ma le vendite non sono state buone. Da quanto scrive Sergio Bonelli e Ambrosini stesso nell’introduzione all’ultimo numero, si tratta di nicchie di lettori, affezionati, attenti, intelligenti, curiosi, stimolanti, blabla, ma pochi.
Nell’introduzione di Peter Milligan al secondo tradepaperback di Young Liars di David Lapham (di cui vi parlerò presto), l’autore britannico ammette che ci sono storie che necessitano di essere di nicchia, perché quello che viene raccontato è inaccessibile, si potrebbe dire, alla coscienza collettiva di massa.
Se vale per Young Liers, non è il caso di Jan Dix.
Dix è un Investigatore dell’Arte, o qualunque altra definizione inappropriata vuoi usare. Non vuol dire altro che Arti Figurative più delitti o misteri più passioni umane.
Ha base ad Amsterdam ma ha respiro internazionale. Il protagonista soffre della peggiore sindrome dell’antieroe, ovvero un’ambiguità che sfocia nell’anonimato che, si direbbe dal finale, porta all’anomia.
Ambrosini ha vocazioni chiare. Utilizzare forme da fumetto popolare per avvicinarsi al fumetto artistico, colto e… intimista. Insomma, in qualche modo, boicottare l’avventura in funzione dei sentimenti, quelli "adulti", quelli "veri", quelli della depressione dell’età adulta irrisolta.
Dix è vittima del suo autore, dei suoi lettori, delle sue passioni da protagonista anonimo e nell’ultimo numero lascia questo triste mondo scaraventandosi con la sua auto contro un treno. La sua vita termina in quello che si potrebbe dire il numero più bello della serie, non a caso scritto e disegnato dal solo Ambrosini, quello più emblematico, che segna in modo chiaro l’insuccesso del progetto dell’autore.
L'errore: l’arte figurativa così come è osservata dall’autore è un’arte morta. È quella dei musei e dei saggi stratificati. Paolo Conte, in una sua canzone, diceva
È gente per cui le arti stan nei musei
Tutto qui. I Monet, i Picasso, i Tintoretto, … avvicinati con sguardo per certi versi esoterico, simbolico, non appartengono più alla nostra cultura del quotidiano. Il che naturalmente non dovrebbe precludere nessuno a parlarne. Ma Ambrosini non riesce a riportare questi autori e le loro opere nel cuore della nostra quotidianità. Da qui, si direbbe, il rifugio in un mondo "adulto", dove adulto vuol dire privo di speranza, dove l’irrazionale è incompreso, è subito, è depressivo. Jan Dix sembra un rifugio, dove il fumetto diventa torre rialzata lontana dal mondo, chiusa dalle mura della griglia, della forma, del pubblico bonelliano, isolata dall’impossibilità di un linguaggio inadatto, sterile.
Non sono mancate storie coinvolgenti e riuscite: La guerra (con Bacilieri), Una tragedia americana (con Mammucari) e questo finale Lo sguardo cieco. La solitudine di Jan Dix, che si ritrova schiacciato dalla nostalgia per la propria madre scomparsa da anni, è un atto narrativo generoso e onesto di Ambrosini, che trova una voce autentica e senza mediazioni e che sfida tutte le logiche base dell’avventura bonelliana. Un non-Bonelli, insomma, per un finale senza consolazione. Per l’autore, che torna a lavorare per Dylan Dog, per il protagonista, per le Arti Visive, per il fumetto non-avventura in Bonelli. Un punto di non ritorno?
Harry.
Presto, ancora...
del mettersi a nudo, ovvero delle parole di Gipi
o di Andrea Pazienza
ovvero
per comunicare si deve avere qualcosa da dire?
Harry
mercoledì 23 giugno 2010
Crisi permanente
Non ti arrabbiare.
Parti dall’ovvia constatazione che ogni discussione è minata, al suo fondo, da una distorsione causata dalla necessità di avere ragione. Ogni parte in causa vuole affermare la propria posizione. C’è un’esigenza biologica primaria dietro a ciò. Quella stessa esigenza muove i nostri limiti, spingendoci al confronto, ma, ahimè, più spesso per affermarci nei nostri confini che per aprirci a nuove possibilità. La povertà della nostra ricchezza intellettuale ci rende snob e sordi. E la comunicazione è interrotta, difficoltosa e sterile. Ognuno per sé, si potrebbe dire.
La fenomenologia del dibattito fumettistico è riassunto in una parola: sordità.
E c’è molta, moltissima intelligenza nel mondo del fumetto. Quindi, più sordità intellettuale, con un bel pizzico di ipocrisia e una sana dose di insofferenza.
Concetti sordi: il fumettista giovane è giovane e non ha spazio per affermarsi, quello vecchio è vecchio e vuole approfittare della sua fama, l’editore ti vuole fottere, l’editore non ha soldi, il fumetto non vende, il distributore è cattivo, la fumetteria non sa fare il suo lavoro, la fumetteria è vittima, …, il fumetto si fa per passione, il fumetto si fa per soldi.
Nell’arena delle profezie che si auto-realizzano, se sono un giovane autore determinato, posso esordire in Bonelli, su Nathan Never, dopo una brevissima gavetta; se sono un giovane autore ricco di talento ma incerto e debole, non esordirò mai. Peggio ancora se ho velleità artistiche.
Ecco, leggo sul blog di Daniele Barbieri diversi tentativi di inquadrare il problema della questione “arte”, e mi tolgo il cappello, come farebbe Borges con Don Chisciotte e i suoi mulini. Discutere di arte nel mondo del fumetto, negli anni Duemila, per molti addetti ai lavori, assume la forma della pedanteria retrograda, del voyeurismo se non dell’onanismo. Perché, nella crisi delle idee e dei riferimenti, il tentativo di categorizzare appare futile. Ma una discussione da dove deve partire?
Sceneggiatori affermati che ambiscono al ruolo di impiegati seriali, intanto, cercano rifugio nella lode all’intrattenimento, come forma massima di impegno sociale. Verrebbe da dire, un fumetto socialmente utile, contro un fumetto artistico, pretenzioso e inutile. Ma con quale possibilità di mediazione? A difesa ognuno del proprio diritto di avere un posto ed esistere.
Le categorie sono vecchie, perché il pensiero si è fermato. Si è fermato alla “crisi permanente”.
E non mi riferisco a quella delle vendite. Non solo. Ma allo stato di crisi permanente della nostra cultura, della nostra economia, della nostra società, della nostra comunità, del nostro vicinato, del nostro senso di esistere come persone.
In un tale confine, esistenziale e culturale, diventa impossibile innanzitutto pianificare e investire per il futuro (impossibile prevedere un futuro), e soprattutto impossibile cambiare paradigma. La paura annulla il movimento, del corpo e della mente. Piuttosto che buttare a mare paradigmi che non funzionano, ma sui quali si fondano profezie, concetti sordi, rapporti di potere, sistemi aziendali e produttivi, si lotta per mantenere le posizioni. È in questo scenario, credo, che si può comprendere, per esempio, l’azione editoriale della Sergio Bonelli Editore che modifica i formati per non modificare nulla. Romanzi, maxiserie, miniserie che hanno tutte lo stesso codice, la stessa cornice testuale di riferimento. Che parlano lo stesso linguaggio ripetuto alla nausea. È alla luce del concetto di crisi permanente che si può comprendere l’idea dell’editore di produrre i fumetti come trent’anni fa, ma con un progetto a breve scadenza. Fumetti come il latte. Non certo nel tentativo di aprire nuove fasce di mercato, nuovi linguaggi, nuovi movimenti culturali e… artistici! A quale scopo, se la crisi spazzerà presto via tutto?
La crisi come valore diviene il motivo di azione dei piccoli editori, laddove si investe in proprio per realizzare un prodotto che non verrà promosso, sviluppato nel tempo, traghettato al lettore. Siamo nel cuore del concetto di tempo breve. Lo sforzo editoriale si esaurisce con la stampa del prodotto. La crisi giustifica l’inazione, l’inerzia, l’assenza di progettualità, l’impossibilità di pensare a sinergie nuove ed evolute.
E i fumettisti non sanno di quale crisi perire. Quella della rassicurante ripetizione infinita di modelli logori e culturalmente (artisticamente) sterili. Quella della coraggiosa e militante lotta dei modelli instabili della piccola produzione, nell’idealismo espressivo dell’artista romantico, solo, incompreso e… tristemente ignorato dai lettori.
Usciamo dalla crisi.
La critica ha una grande responsabilità: quella di suggerire altri possibili paradigmi. Di tornare a discutere del rapporto tra forma di espressione, arte (grazie Barbieri), serialità, formati, meccanismi di mercato. Di essere da esempio per un confronto aperto e non schierato su pregiudizi e posizioni di potere. Di sostenere e promuovere iniziative culturali rilevanti, opere e autori nuovi. Di riportare al centro del dibattito le contraddizioni di una forma di espressione impura, puttana e meticcia, che più di altre può (potrebbe) interpretare questo tempo impuro, puttano e meticcio e mettere al sicuro un patrimonio artistico che è misconosciuto, in Italia, da un’assenza generale di interesse per la cultura (assenza sociale, politica, educativa - comics day?) e da un’incapacità diffusa di pensare al fumetto come arte viva e virale. Io sono contrario alle vaccinazioni. I virus culturali, artistici e comunicativi non devono avere un antidoto già sintetizzato. Questa è la scienza medica della paura. Della crisi programmata. Io voglio essere contaminato e diffondere quel virus ad amici, parenti, conoscenti, riconoscenti e indifesi immunitari.
La vita è una crisi permanente. Iniziamo a parlare del fumetto come di fronte alla vita. Senza prenderci per il culo.
Harry.
venerdì 30 aprile 2010
Arte varia
Le condensazioni arrivano da ogni parte, soprattutto quando si è stanchi di osservare sempre nella stessa direzione.
Attirato dal titolo e dalla copertina italiana (Adelphi 424), mi trovo invischiato nell’appassionante lettura del miglior romanzo dell’inglese W. Somerset Maugham (il migliore, essendo il suo primo che leggo!), La luna e sei soldi (The Moon and sixpence, 1919).
Il tono è più o meno esemplificato da questo breve, abbagliante saluto al termine della lettera di addio alla moglie da parte del protagonista:
Non tornerò. La mia decisione è irrevocabile.
Tuo sempre,
Charles
La comunicazione di un addio irrevocabile è chiusa dalla frase “tuo sempre” che è al contempo ferocemente ironica e vagamente trascendente.
D’altra parte, come dirà più avanti Maugham di sé stesso:
Non avevo ancora imparato com’è contraddittoria la natura umana; ignoravo quanto c’è di posa nel sincero, di bassezza nel nobile, e di bontà nel reprobo.
Il protagonista del romanzo è un Paul Gauguin appena mascherato e l’esperimento di Maugham è un’appassionante finta biografia, verosimile quanto felicemente pretestuosa.
L’audacia di Maugham, che nel primo dopoguerra gioca con le aspettative del lettore “inventando una storia vera”, è importante ma ancor di più lo è il suo sguardo sull’arte e la creatività.
Innanzitutto quel che pensa in merito all’essere un autore autonomo e disinteressato del parere altrui:
Quando una persona dice di non curarsi di quello che pensano gli altri, il più delle volte si illude. Generalmente intende dire soltanto che suole fare come le aggrada, confidando che nessuno verrà a conoscere le sue stravaganze; o, tutt’al più, che è disposta ad agire in contrasto con l’opinione della maggioranza perché è sorretta dall’approvazione di chi la pensa come lei. Non è difficile essere anticonformisti agli occhi del mondo quando il tuo anticonformismo non è che il conformismo della tua cerchia. E te ne viene una dose smodata di stima per te stesso. Hai il compiacimento del coraggio senza l’incomodo del pericolo.Poi una luminosa riflessione sulla bellezza, e sul rapporto tra artista e fruitore:
Perché pensare che la bellezza, la cosa più preziosa del mondo, se ne stia come un sasso sulla spiaggia, a farsi raccogliere per ozio dal primo sbadato passante? La bellezza è qualcosa di strano e meraviglioso che l’artista plasma dal caos del mondo nel tormento della sua anima. E quando l’ha creata, non a tutti è dato comprenderla. Per riconoscerla devi ripetere l’avventura dell’artista. È una melodia quella che lui ti canta, e per riudirla in cuor tuo ti occorre esperienza, sensibilità e immaginazione.La scrittura e l’impostazione sono geneticamente letterarie. C’è un passo piuttosto lungo, che non riporto per non risultare eccessivamente pedante, nel quale Maugham cerca di descrivere la pittura di “Gauguin” e quello che la muove. Le parole arrivano in modo indiretto, perché faticano a rappresentare il dato visivo della pittura. Per quanto Maugham ci provi, non è sul piano visivo che può avvenire il processo di mimesi e di sintesi (sintetismo?!), ma su quello logico, concettuale e verbale. E infatti, l’impressione più forte derivante dalla lettura, è che Maugham usi la forza evocativa dell’opera di Gauguin come pretesto per parlare di letteratura, della vocazione artistica in questo ambito e, di riflesso, del proprio percorso artistico. Tanto che in un passaggio:
Mi chiedo se potrei mai scrivere su un’isola deserta, con la certezza che nessuno tranne me vedrà mai quello che ho scritto.
Altrettanto interessante è uno scambio nel quale due personaggi secondari divergono sul concetto di successo di pubblico, o su come riconoscere la validità di un’opera. Da notare che, ironicamente, il primo interlocutore è un pittore di buon successo commerciale privo di qualunque talento, come riconosce egli stesso, al contrario di “Gauguin” che nel romanzo è senza soldi e privo di riconoscimento da parte di critica e pubblico (almeno finché in vita). Il secondo interlocutore è un rigattiere, quindi, in sostanza, un commerciante:
- E lei, allora, come lo riconosce il talento?Ma se è vero, come dice Maugham (che nel romanzo interpreta sé stesso), che:
- C’è solo un modo. Dal successo.
- Filisteo!
- Ma pensi ai grandi artisti del passato, Raffaello, Michelangelo, Ingres, Delacroix. Tutti hanno avuto successo.
- Andiamo o quest’uomo lo uccido.
Non è vero che la sofferenza nobilita il carattere. Così fa a volte la felicità; la sofferenza, per lo più, rende gli uomini meschini e vendicativi.
Viene da pensare che la maggior parte degli artisti più importanti dello scorso secolo (e non solo), in ogni disciplina, siano stati tra gli uomini più spregevoli della vita umana: Van Gogh, Jim Morrison, David Foster Wallace, Miles Davis, … per dire dei primi nomi che mi sono venuti disordinatamente in mente.
Come detto, il tentativo di Maugham si rivela efficace quasi esclusivamente sul piano letterario. MA cosa accadrebbe se un artista, attraverso il mezzo (ig)nobile e bastardo del fumetto, provasse un diverso processo di sintesi, mimetizzandosi anch’egli con il percorso di vita di un pittore, appropriandosi delle sue opere e rielaborando sul piano visivo il suo immaginario? Se l’autore ha l’intelligenza di Sfar, ne nascerebbe probabilmente un lavoro verosimile, nudo, terreno e volgare come Pascin.
Pascin è una sorta di gemello diverso di La luna e sei soldi, un corrispettivo in linguaggio fumetto. Gemelli separati da tante, troppe distanze (temporali, culturali, di mezzo espressivo, …) per azzardare un vero confronto. Ma un accostamento, perché no?
Laddove non può Maugham, con la letteratura, può Sfar con la sua sfrontatezza e con il fumetto: le tele di Pascin alias Julius Mordecai Pincas diventano pezzi di narrazione, tavole di fumetto, in un gioco di specchi nel quale Sfar si identifica con il pittore, e questi diviene il fumettista, uniti dalla comune insofferenza per la vita e dall’irresistibile vocazione artistica.
Pascin e La luna e i sei soldi sono entrambe opere originali e riuscite. Opere felici, che possono imprigionare il lettore e rivelano moltissimo sulla vita. Questo passaggio, ancora dal romanzo di Maugham, potrebbe essere attribuito a molti autori di fumetti, di ogni generazione:
A quanto capivo dipingeva con grande difficoltà; e nella sua renitenza a cercare aiuto da chicchessia perdeva molto tempo per trovare da solo la soluzione di problemi tecnici che le generazioni precedenti avevano già risolto uno per uno. Mirava a qualcosa, a cosa non sapevo, e forse non lo sapeva nemmeno lui; e di nuovo ebbi, più forte, l’impressione di un uomo posseduto.
Quel che mi piace pensare è che vi sia la possibilità, ancora oggi, di trovare artisti realmente posseduti da una vocazione, da una chiamata, che li costringerebbe a realizzare le proprie opere anche su un’isola deserta. In attesa, forse, di una futura, impensabile, colonizzazione.
Harry
giovedì 31 dicembre 2009
giovedì 19 novembre 2009
martedì 6 ottobre 2009
Oggi rifletto sul formalismo - parte 4 di 5
Qui la seconda parte.
Qui la terza parte.
Ora la quarta parte.
A questo punto, giunto alla quarta puntata, apro una breve parentesi che chiamerei: l’impossibilità di una critica oggettiva.
La vocazione all’oggettività scientifica è un richiamo fortissimo per noi occidentali. Deriva da un lato dall’ansia per il controllo della materia di studio, dall’altro dalla volontà di comunicare a tutti in modo chiaro e univoco. E ancora, forse, dal desiderio dell’ego di voler convincere tutti delle proprie affermazioni.
In ogni caso, ci sbagliamo.
Per le ragioni esposte nel precedente capitolo, a cui rimando, il fumetto in particolare è un oggetto di studio e di analisi molto stratificato, complesso nei suoi numerosi collegamenti (sensoriali e logici), al punto da essere, come strumento espressivo, un perfetto esempio di semplificazione delle complessità. Ci vedo l’impossibilità di un giudizio unico, ma anche di un approccio unico.
In un’analisi critica di un fumetto, quindi, è inutile perseguire l’oggettività di pensiero (già di per sé un paradosso in termini). È più importante ricercare la chiarezza e l’argomentazione. È importante comunicare al lettore (più o meno esplicitamente) le regole, che sono le chiavi di lettura, e l’approccio che si intende utilizzare.
Un esempio. Avendo toccato il tema del formalismo, ho accennato ai lavori di Chris Ware come esempio massimo di questa modalità espressiva nel fumetto. Su questo piano, la sua graphic novel Jimmy Corrigan è un’opera perfettamente riuscita, molto più che il già citato Figlio di un preservativo bucato di Howard Cruse. Ma se spostiamo il punto di vista e il focus dell’analisi, per esempio sull’efficacia nella rappresentazione di un periodo storico specifico, Figlio di un preservativo bucato ha pochi eguali. L’errore che si compie spesso nelle analisi critiche meno consapevoli, è quello di esprimere un giudizio di merito su un lavoro senza chiarire da quale punto di vista lo si sta osservando, con quali strumenti di analisi e secondo quali criteri.
E il gusto personale?
Il gusto personale è importante, perché l’azione di critica non può e non deve essere un esercizio freddo e sterile. Tuttavia, esso deve essere filtrato e, ancora una volta, espresso chiaramente. Concordo quindi con chi sostiene che l’esercizio critico è un processo in divenire, sia per le continue sollecitazione e relazioni che il contesto esterno muove rispetto all’interpretazione di un’opera, sia per la crescita (di sensibilità, culturale, interpretativa) alla quale ogni critico serio si apre giorno dopo giorno.
Alcuni fisici contemporanei, a proposito della possibilità di conoscere il mondo che ci circonda (di cui, lo ricordo ai più distratti, il fumetto fa parte), sostengono che quello che osserviamo è come una sommatoria armonica delle percezioni di tutti i presenti. Non osserviamo il mondo, ma la sintesi dei mondi percepiti da tutti i presenti. Non solo, dentro ai mondi di tutti i presenti ci sono infiniti mondi, infinite possibilità di esistere.
Al di là del valore metafisico, trovo che questo concetto sia decisamente adatto a quello strano mondo che è il fumetto. La soggettività e la variabilità delle interpretazioni di questo medium è altissima, perché il lettore ha ampio spazio di agire a diversi livelli: nel dare significato e aggregare i segni tra loro, nel congiungere le rappresentazioni simboliche dei testi scritti con quelli del disegno, nel riempire di contenuto (emozioni, azioni, pensieri, …) lo spazio tra una vignetta e l’altra, nel collegare svariati riferimenti culturali allo stile personale dell’autore, ecc. Riuscite a sentire quanto margine di possibilità soggettiva c’è in ognuno di questi passaggi?
Poco importa se, poi, la maggior parte delle proposte a fumetti boicottano alcune di queste possibilità attraverso la piatta ripetizione automatica.
La cosa straordinaria, forse, è la capacità dei fumetti più riusciti di mantenere ed esaltare questo spazio di immaginazione personale e al contempo di raccontare chiaramente una storia precisa, definita e condivisibile tra molti.
Nella prossima e ultima puntata, arrivo a Taniguchi.
Harry
(continua)
venerdì 2 ottobre 2009
Oggi rifletto sul formalismo - parte 2 di 5

Qui la prima parte.
Ora la seconda parte.
Come sappiamo, puntando il dito alla luna, potremmo dimenticare la luna e osservare solo l’estremità di una mano, ricercando crateri e dune tra lo sporco dietro a un’unghia.
Questo accade, per lo più, quando quello che stiamo osservando si presenta come un insieme di stimoli complessi, stratificati e multipli. Il fumetto è una delle forme di comunicazione più ambigue che conosca, costituita dall’accostamento di linguaggi diversi, da associazioni multiple e contraddittorie, dall’esaltazione delle idiosincrasie degli autori.
È per queste ragioni che il fumetto seriale e/o popolare si basa molto sul concetto di riproduzione e di ripetizione, per sviluppare una familiarità nel lettore che non disorienti eccessivamente, all’insegna di una semplicità che è, più volte che non, vicina alla semplificazione piuttosto che all’essenzialità. Pensiamo, per esempio, al realismo avventuroso di casa Bonelli. Il meccanismo produttivo di tali fumetti è molto impegnativo, sia per numero di tavole/ore di lavoro, che per l’attenzione alla verosimiglianza dei disegni rispetto alla realtà, alla vicinanza con un reale che, per quanto addomesticata, richiede molto studio e attenzione. Tale procedimento, tuttavia, richiede agli autori un minor sforzo di lavoro sul simbolo, sul linguaggio, sulla forma, perché, come dire, pre-costituito, già dato (sul piano del reale), da un lato, già acquisito (sul piano formativo e culturale), dall’altro. Per il lettore è lo stesso. Il lavoro di interpretazione di quanto si sta leggendo, osservando e vivendo è semplificato da quanto già acquisito con l’esperienza.
Al contrario, un fumetto più personale, autoriale, slegato da certi meccanismi e strutture pre-costituite, richiede all’autore un maggior sforzo di immaginazione per ri-definire simboli, accostamenti, relazioni, linguaggi e al lettore per interpretarli e farli propri.
 Nei casi in cui la ricerca porta l’autore a creare un fumetto estremamente simbolico ma semplice, come certo minimalismo moderno (Jason) o alcuni esperimenti di Trondheim (Mister I, A.L.I.E.E.E.N.), al lettore non viene richiesto soltanto uno sforzo di comprensione o interpretazione “linguistica”, ma anche un’apertura mentale e concettuale che gli permetta di accettare e di assorbire un tratto e una storia diversi dalle aspettative (si pensi all’effetto che fanno le storie autobiografiche di Jeffrey Brown).
Nei casi in cui la ricerca porta l’autore a creare un fumetto estremamente simbolico ma semplice, come certo minimalismo moderno (Jason) o alcuni esperimenti di Trondheim (Mister I, A.L.I.E.E.E.N.), al lettore non viene richiesto soltanto uno sforzo di comprensione o interpretazione “linguistica”, ma anche un’apertura mentale e concettuale che gli permetta di accettare e di assorbire un tratto e una storia diversi dalle aspettative (si pensi all’effetto che fanno le storie autobiografiche di Jeffrey Brown).Ed allora, cosa succede al lettore quando si avvicina a un fumetto diverso dal quale è abituato?
Nella mia esperienza, il primo approccio e il primo livello di attenzione riguarda l’oggetto “fumetto”, o “libro-fumetto”. Lo osservo nel suo insieme, appunto come “oggetto neutro”. Ed è per questa ragione, credo, che si è sviluppata negli anni una grande attenzione al design dell’oggetto-fumetto, ancor più per gli autori più vicini al formalismo (come Ware, appunto).
In un secondo momento, sfoglio velocemente le pagine, per recepire le sensazioni che l’impatto grafico complessivo, lo stile, mi comunicano. Non c’è il tempo, in questa fase, di soffermarmi sui particolari, ma sulle tavole nel loro insieme sì. È in questo momento che sono aperto alla comprensione di segnali di un approccio formale, che comprendo l’equilibrio delle tavole nel loro insieme e delle tavole tra loro. È un’attenzione che in larga parte prescinde dal contenuto, dalla storia e che si avvicina alla “lettura” propria delle arti visive, dove si cerca di scoprire una narrazione tra i segni. Questa fase è quella che più spesso porta a delusioni, perché sono molti meno di quanto si vorrebbe i fumetti che funzionano da questo punto di vista. Ma è naturale che sia così, e rivela in modo netto la specificità del fumetto rispetto alle arti visive. Sfogliare velocemente Figlio di un preservativo bucato di Howard Cruse, per fare un esempio, può lasciare molto freddi, distaccati e sono pochissimi i segnali “superficiali” che possiamo cogliere a indicarci quanto sia in realtà buona quella storia.
Tali segnali si manifesteranno solo nella fase successiva, quella nella quale si inizia effettivamente la lettura.
Harry
(continua)
giovedì 13 novembre 2008
Interni

Ausonia da tempo afferma con ideologia militante la necessità che le forme artistiche tornino a un’autenticità espressiva indipendente dai criteri commerciali e dal mercato.
Nell’ambito fumettistico, più volte ha posto la questione riaffermando la conflittualità tra prodotto commerciale e autoriale, con argomentazioni non banali e non semplicistiche quanto questo periodo potrebbe far supporre.
Interni, il suo ultimo lavoro, sembra accomodarsi in questo solco, a dispetto di quello che l'autore dichiara, laddove il protagonista è un autore affermato di romanzi di genere in crisi di identità.
Detto che l’approccio, come sempre, è originale sia sul piano della scrittura che del disegno, verrebbe da chiedersi perché tutta questa perdita di tempo. Un ordito talmente complesso a sostegno di un inganno futile, facilmente superabile con, per esempio, il “trucco” dello pseudonimo, non è giustificato se non dalla necessità dell’autore di voler a tutti i costi affermare l’Idea che il prodotto commerciale rende schiavi non solo i lettori ma, per primi, gli autori stessi.
Al che mi verrebbe da chiedere, siamo sicuri che affermati autori “popolari” non avrebbero la possibilità editoriale per realizzare opere più libere, autonome, autoriali, con conseguente successo di pubblico? È possibile che semplicemente questi autori non ne abbiano la voglia, non ne sentano la necessità?
È, questa possibilità, conseguenza dell’intorpidimento derivante dal pensiero commerciale e commercializzato che sottostà alle regole del prodotto di massa?
A giudicare dal risultato espressivo rappresentato da Interni, vien quasi da dire che, in questo caso, le riflessioni sul fumetto popolare abbiano contaminato negativamente il fumetto autoriale, dando origine a un prodotto sterile. E autoreferenziale. E inconsistente nelle sue motivazioni psicologiche ed euristiche. Peccato.
Harry.
Tutti i testi di questo blog sono (c) di Harry Naybors, salvo dove diversamente indicato.
Puoi diffonderli a tuo piacere ma esplicitando sempre l'autore e/o la fonte.
La versione a fumetti di Harry è (c) di Daniel Clowes.