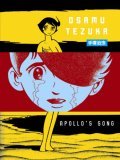Sergio Brancato chiacchiera con Davide Occhicone su LoSpazioBianco. Un'intervista densa e stimolante.
Prima, un chiarimento semplice quanto necessario, a proposito della critica amatoriale, che condivido completamente, perché in fondo è di questo che parlo ogni giorno:
I giornalisti che scrivono per i giornali sono molto pochi, quindi la critica diventa sempre più, oggi, un esercizio amatoriale. Attenzione: non dilettantistico, ma amatoriale nel senso di motivato passionalmente, di un desiderio di interazione con la comunità di riferimento.
La chisura dell'intervista, che riflette sullo specifico del fumetto nel mondo odierno, mette in luce la sua caratteristica meticcia e, forse con un moto di orgoglio quasi eccessivo, ne evidenzia una portata proto-rivoluzionaria:
[...] il fumetto riemerge in nuove forme, ad esempio come laboratorio sperimentale sottostante l’evoluzione del cinema e degli audiovisivi in generale. Oppure, come sostiene Daniele Panebarco, leggendario comic-maker degli anni ’70, introducendo nella cultura di massa quella modalità di racconto ipertestuale, basata sul costante rimando tra diversi codici di comunicazione, che è alla base dei linguaggi digitali. In altri termini, senza la preesistenza del fumetto, difficilmente si sarebbero sviluppate le forme di comunicazione attualmente in voga presso i giovani.Un sotto-testo culturale, quindi, quello fumettistico, che secondo Brancato sarebbe stato funzionale all'evoluzione dell'era digitale.
Infine, riprendo un passaggio che non mi sento di condividere, e che è figlio di un pessimismo educativo che potrebbe essere superato:
No, non credo che portare il fumetto nelle scuole porterebbe grandi vantaggi, finirebbe per diventare come la Divina Commedia, un’opera bellissima ed entusiasmante che abbiamo davvero scoperto, da soli, dopo che aveva finito di essere un obbligo didattico.Secondo questa logica, l'insegnamento scolastico andrebbe via via impoverendosi sempre più, senza alcuna possibilità di rinnovarsi al passo con i tempi. Piuttosto che non far entrare il fumetto nelle scuole, sarebbe importante formare gli insegnanti affinché lo sappiano insegnare. Se non è raro trovare insegnanti inadeguati a trasferire le emozioni di alcuni capolavori (come la Divina Commedia citata da Brancato), ritengo che la scuola sia ancora oggi un luogo dove i giovani possano ricevere stimoli, fascinazioni e vocazioni per il loro futuro. Non togliamo a priori questo potenziale. Piuttosto, ripensare alla scuola pubblica, senza maschere ideologiche a coprire tagli indiscriminati, potrebbe comprendere anche riflettere sul ruolo del fumetto come materia di studio e/o come strumento di insegnamento.
Harry
(tutta l'intervista qui)