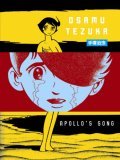Il Dylan Dog Color Fest, albo fuori collana con cadenza variabile, è stato finora un contenitore vuoto e privo di significato. Un prodotto commerciale che ha puntato su due aspetti: il colore (non sempre utilizzato in modo efficace); la perizia grafica di alcuni disegnatori (in alcuni casi con un approccio molto particolare, come nel Color Fest umoristico di qualche mese fa). Ma che si è rilevato assolutamente piatto e monocorde dal punto di vista delle storie, delle sceneggiature, delle interpretazioni. L’ultimo esperimento, con la sesta uscita, è un Color Fest tutto al femminile, ovvero realizzato interamente da sceneggiatrici, disegnatrici, coloriste e letteriste donne.
Ma facciamo un passo indietro.
Gli sceneggiatori di Dylan Dog sono stati quasi esclusivamente uomini, a partire dal loro creatore, Tiziano Sclavi. Unica eccezione davvero rilevante, la sceneggiatrice Paola Barbato (presente anche in questo Color Fest), che per molti, ma non per il sottoscritto, ha preso il testimone creativo di Sclavi. Il padre di Dylan Dog ha dimostrato negli anni una grande capacità nel tratteggiare caratteri e sensibilità dalla spiccata vicinanza con il mondo femminino. C’è sempre stato, in Sclavi, un bisogno profondo di ricerca, di indagine che, senza mai tralasciare alcune fondamentali logiche proprie del fumetto d’avventura, ha negli anni avvicinato moltissime lettrici a Dylan Dog. Il successo, in questo senso, non è stato guidato da un’intenzione esplicita come quella di Giancarlo Berardi e la sua Julia, che dell’osservazione attraverso una sensibilità femminile fa una delle sue matrici costitutive, ma da un’innata, feroce urgenza di Sclavi, che ha saputo aprire lo sguardo e il genere, raggiungendo potenzialmente tutti.
L’assenza di Sclavi, negli anni, ha pesato molto anche in questa direzione. I vari successori non hanno saputo sviluppare uno sguardo proprio, inedito, vero. Hanno imbastito teatrini più o meno efficaci che hanno avuto per protagonista la marionetta Dylan, il suo mondo e i suoi comprimari.
Una messa in scena gelida che, salvo alcune rare eccezioni (penso in particolare ad alcuni lavori di Michele Medda) non ha mai convinto davvero. Di questo fallimento espressivo (prima ancora che narrativo o editoriale) si è detto molto senza analisi davvero efficaci. Quel che è certo è che di Sclavi Dylan Dog è stato una manifestazione forte, credibile e reale. E come sappiamo, la realtà sfaccettata dell’angoscia, del disagio e della sensibilità che Sclavi ha messo in scena hanno una forte connotazione femminina.
Torniamo al Color Fest.
C’è in Dylan Dog, il personaggio, un’impalcatura narrativa potenzialmente anti-femminina forte e radicata, che è quella del rubacuori e dell’amante sempre insoddisfatto. Su questo tema, Barbato ha più volte giocato, cercando da un lato di alleggerirlo, deriderlo e umanizzarlo, e al contempo di non banalizzarlo. Un tentativo consapevole, forse legato a un disagio che la sceneggiatrice donna si trova a dover affrontare, per andare oltre il solo meccanismo narrativo e riempirlo in qualche modo di senso. È qualcosa che gli altri sceneggiatori, uomini, per ovvie ragioni hanno tenuto in secondo piano o trattato con estrema superficialità. Ad eccezione, di nuovo, di Scalvi. Ma se per questi, il Dylan Dog amante e seduttore, oltre che un gioco al servizio della serie, è stato un efficacissimo pretesto per raccontarci vite molteplici e multiple dell’altra metà del cielo, per Barbato finora è stato un tema necessario ma scomodo.
Nel Color Fest, Barbato torna a giocare su questo tema ribaltando abilmente la prospettiva. Osserviamo il bisogno di Dylan, un bisogno tutto maschile, potremmo dire etologico (o nevrotico?), attraverso gli occhi di un’amante quasi perfetta e gelosissima. Si dice che la gelosia sia prima di tutto un sentimento femminile. Vero in parte. Le tradizioni culturali e la cronaca nera ci dicono di molti e spaventosi modi di agire la gelosia da parte dell’uomo (dalla possessività, alle violenze fisiche, allo stalking, ecc.). Eppure, la gelosia come forma subdola e invadente, ossessiva, che non si manifesta apertamente, ma lavora nel profondo e in territori immaginari prima che reali, sembra essere più vicina all’universo femminile. È di questo sguardo che Barbato ci parla, con l’aiuto di Lola Airaghi alle chine, sempre con notevole divertimento e gioco ma anche con una chiarezza dell’intenzione narrativa che coinvolge e incuriosisce. Airaghi si presta all’esperimento con buona padronanza e guardando, stilisticamente, al canone di Bruno Brindisi. Per inciso, un tratto meno derivativo sarebbe stato ancora più efficace nel raccontare questa piccola storia.
Certo, l’amante assassina di Barbato e Airaghi alla fine del racconto ricorda fin troppo una maschera del mondo psicotico di Batman, eppure è l’insieme sintetico ma chiaro delle reazioni di Dylan Dog che risulta efficace e credibile, per quanto estremo, fino al tradimento da lui agito nei confronti della presunta amante perfetta. L’idea della perfezione è forse una delle paure più angoscianti della nostra vita. E l’ossessione del controllo uno degli specchi nevrotici più pervasivi.
Harry
(continua con l’amabile Vanna Vinci…)
sceneggiatura di paola barbato, disegni di lola airaghi